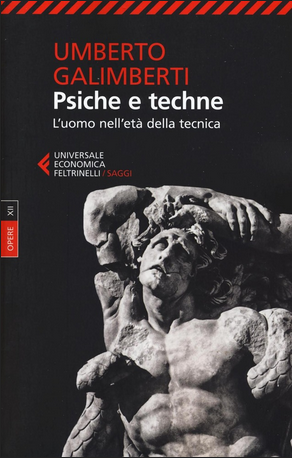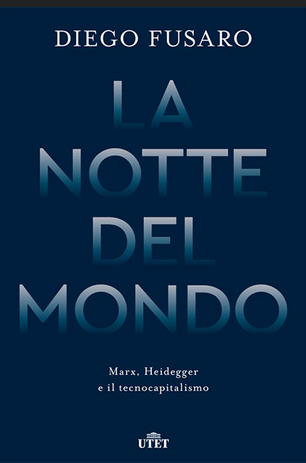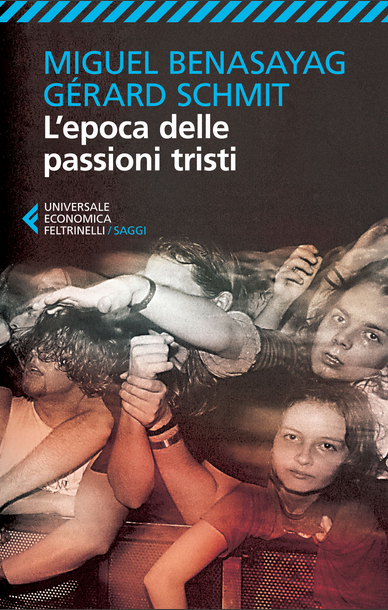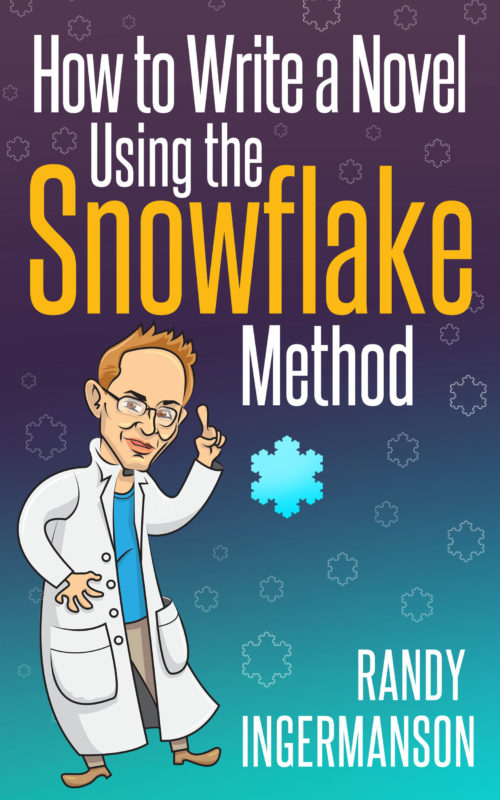 Sono istintivamente contrario a scuole di scrittura o manuali di scrittura. Sono cioè dalla parte di tutti quei (penso numerosi) scrittori che sostengono che a scrivere non si può insegnare. Sarebbe, in sostanza, una di quelle cose che hai o non hai. D’altra parte una volta ho sentito un’intervista ad un insegnante di scrittura creativa che diceva che i suoi corsi servivano ad essere pronti quando l’ispirazione fosse venuta, a mettere insomma insieme una sorta di valigetta degli strumenti, e l’ho trovata un’affermazione sensata. Io ho un background semiotico, considero Umberto Eco un maestro, dunque non sono a digiuno di materie quali ad esempio la narratologia. Per chi non avesse mai sentito parlare di questi temi, forse, un corso di scrittura creativa potrebbe aiutare. D’altra parte è anche vero che molti scrittori di successo, forse la maggioranza, hanno imparato leggendo e scrivendo. Altri vengono invece da scuole di scrittura. Pare che in questa, come in molte altre questioni, non vi sia una ricetta fissa.
Sono istintivamente contrario a scuole di scrittura o manuali di scrittura. Sono cioè dalla parte di tutti quei (penso numerosi) scrittori che sostengono che a scrivere non si può insegnare. Sarebbe, in sostanza, una di quelle cose che hai o non hai. D’altra parte una volta ho sentito un’intervista ad un insegnante di scrittura creativa che diceva che i suoi corsi servivano ad essere pronti quando l’ispirazione fosse venuta, a mettere insomma insieme una sorta di valigetta degli strumenti, e l’ho trovata un’affermazione sensata. Io ho un background semiotico, considero Umberto Eco un maestro, dunque non sono a digiuno di materie quali ad esempio la narratologia. Per chi non avesse mai sentito parlare di questi temi, forse, un corso di scrittura creativa potrebbe aiutare. D’altra parte è anche vero che molti scrittori di successo, forse la maggioranza, hanno imparato leggendo e scrivendo. Altri vengono invece da scuole di scrittura. Pare che in questa, come in molte altre questioni, non vi sia una ricetta fissa.
Ho deciso di ‘schedare’ brevemente questo testo perché mi ha aiutato a finire un libro (iCal) in cui per vari motivi ero invischiato da anni, non riuscivo a ‘risolverlo’.


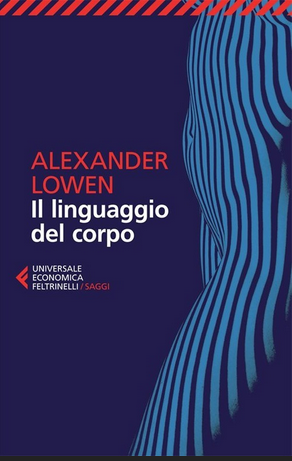 Raccolgo qui di seguito una serie di appunti poco organizzati e un po’ in ordine sparso su questo libro. Metterli a posto prenderebbe troppo tempo.
Raccolgo qui di seguito una serie di appunti poco organizzati e un po’ in ordine sparso su questo libro. Metterli a posto prenderebbe troppo tempo.