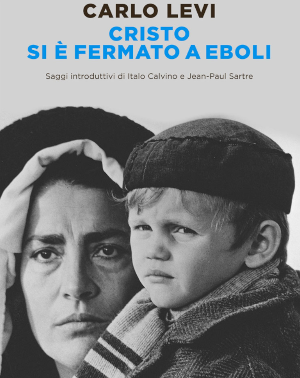
.
Solo qualche parola, prima di lasciarla ad Alicata.
.
Questo romanzo, o forse sarebbe meglio dire memoriale o diario, forse più romanzato nella forma che nella sostanza degli eventi, ha uno stile di scrittura particolare e notevole. Ha avuto un influsso pratico sulla situazione che ha descritto, perché letto e preso in seria considerazione anche dalla politica di allora come una denuncia sociale dello stato in cui si trovavano alcune parti del Mezzogiorno. Descrivendo la stasi, peraltro attiva, del protagonista in confino riesce a rendere in maniera realistica ed artistica allo stesso tempo, al pari di altri grandi romanzi del neorealismo italiano, un’altra stasi, la storia immobile di un popolo senza più speranza, creando una singolare risonanza tra individuo, individui e ambiente sociale nella loro interazione, che appare altrettanto certa ed ineluttabile.
.
Molto difficilmente potrei dirlo meglio di quanto fatto da Mario Alicata, 1954:
.
«Cristo si è fermato a Eboli è forse l’ultima nel tempo, e radicale smentita all’opinione vulgata quanto grossolana che l’arte si spieghi con la storia, con ogni storia aliena, e che non abbia essa potere d’iniziativa e di trasformazione della storia, anche civile e sociale. Quando è arte, s’intende, e non contingente letteratura, come accompagnamento o come sostituto.
Subito dopo la comparsa a stampa del libro, nel 1945, Eugenio Montale coglieva nelle sue fibre, nell’evocazione e contemplazione di un tempo lontano e quasi immobile, e di un’umanità arresa, irredimibile e senza attesa, piegata dal sole induttile tra i sassi e le crete dell’aspro cuore della Lucania, il messaggio piú scotente; e il saggio finale sulla civiltà contadina, sul problema meridionale e sulle autonomie, sostrato intellettuale e morale della narrazione, gli appariva come un naturale spostamento di fuoco da parte di una personalità complessa e coerente di “Faust modernissimo”.
Ebbi il privilegio di leggere Cristo si è fermato a Eboli in manoscritto, sullo scorcio del 1944, poco dopo il compimento del libro nel rifugio clandestino e la liberazione di Firenze in cui fummo compagni.
E appuntai note ora introvabili sul passo di una prosa che si staccava singolarmente dalle esperienze letterarie europee ed italiane (numerose anche allora e spesso intercambiabili) verificatesi tra il ’20 e il ’40 e collegate a diverse notorie “poetiche”, tranquillamente ignorate invece, e di tanto piú in quanto conosciute e valutate; e inventava un suo ritmo che poteva naturalmente, con serena autorità subito impositiva, includere diario e novella, lirismo e introspezione, spettacolo ed empito sentimentale, immagine e tensione morale, in un flusso che dall’inizio alla fine scorreva come un torrente, con la stessa acqua capace di moltiplicarsi in movenze e forme infinite. L’orchestra, il registro di questa prosa che ha dato un unicum alla letteratura italiana non provenivano, com’era ed è tanto solito, da una “coscienza di letterato”, non avevano taccia di professionismo o di obbligate relazioni con un mondo a suo modo chiuso o “speciale” anch’esso, ne erano anzi in un certo senso un’antitesi».



hi